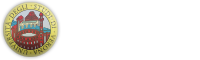- Autori:
-
Ustyuzhaninova, Maria
- Titolo:
-
BIZANTINISMI ED ALTRI ARCAISMI NELLA PITTURA RELIGIOSA DI JACOPO TINTORETTO
- Anno:
-
2016
- Tipologia prodotto:
-
Doctoral Thesis
- Tipologia ANVUR:
- Altro
- Lingua:
-
Italiano
- Parole chiave:
-
Jacopo Tintoretto, Venezia, Cinquecento, arcaismo, anacronismo, bizantinismo, pittura religiosa, iconografia, discesa agli inferi, visione, Concilio di Trento, Riforma Cattolica, purgatorio, preghiera per i morti, mosaico, Basilica di San Marco, San Pietro di Castello, Madonna dell'Umiltà, apocalisse, Donna apocalittica, san Marco, san Luca
- Abstract (italiano):
- Nella storia dell’arte Jacopo Tintoretto è spesso rappresentato come un artista innovatore,
importatore del canone tosco-romano nell’arte veneziana del Cinquecento. La presente tesi
capovolge l’immagine canonica di Jacopo Robusti, restituendogli il legame con la tradizione
arcaica di Venezia. Vista la mancanza, nella città lagunare, dell’eredità classica, abbondantemente
compensata dai manufatti della maniera greca, sia trasportati da Bisanzio che prodotti in loco, il
lavoro si concentra sul rapporto della produzione tintorettiana con l’arte bizantina, lasciando
spazio anche ad altri elementi retrospettivi nella sua pittura religiosa, che rientrano nella
categoria degli arcaismi.
Prendendo in considerazione la relativa marginalità del problema dei bizantinismi ed
arcaismi di Tintoretto, si mira innanzitutto a ricostruire la storiografia di tali elementi nei suoi
dipinti. L’indagine storiografica rileva due linee interpretative riguardo agli elementi retrospettivi
negli studi tintorettiani. La prima tende a scoprire delle imitazioni stilistiche nell’arte del Robusti,
che però non trovano quasi mai un’argomentazione storico-artistica che la legittimi; la seconda,
che ci sembra invece produttiva, vede nei bizantinismi e arcaismi tintorettiani delle allusioni al
tipo iconografico. La necessità degli artisti e dei committenti di ricorrere all’arte del sacro passato
si giustifica attraverso le specifiche esigenze dettate dall’età tridentina e post-tridentina.
La seconda parte del primo capitolo raccoglie le testimonianze cinquecentesche che
definiscono lo status dei manufatti bizantini nella Venezia dell’epoca. La ricezione cinquecentesca
rivela un atteggiamento negativo verso lo stile bizantino, contrastato però dallo status cultuale
dei manufatti stessi. Inoltre, l’arte bizantina a Venezia, anche se definita come della maniera
greca, viene tuttavia spesso contaminata con l’arte gotica medievale, e ciò rende la categoria degli
elementi bizantini dinamica, definibile in termini cronologici più che stilistici. Il riferimento ad un
manufatto bizantino all’interno di un nuovo dipinto va quindi interpretato come allusione al sacro
passato, collegato alla storia mitica dell’origine dello Stato Veneto.
Nel secondo capitolo si esplora il “pattern” che crea la relazione con l’arte del passato
all’interno di un dipinto narrativo di Tintoretto. La Discesa al Limbo di San Cassiano costruisce un
legame con il passato mitico veneziano presentando dei paralleli iconografici diretti con
l'omonimo mosaico marciano e con l'icona bizantina quattro- o cinquecentesca di ugual soggetto.
Il moderno dipinto di Tintoretto non solo si appropria del loro valore cultuale e ideologico
(l’autoidentificazione di Venezia era in gran parte costruita sull’appropriazione dell’eredità
bizantina), ma coglie anche l’occasione per adempiere le nuove richieste poste dalla Riforma
Cattolica. La Discesa al Limbo tintorettiana si rifà ai dipinti veneziani del culto in quanto ritenuti
documenti visivi dell’ortodossia cattolica originaria, e ciò al fine di ripristinare il valore dogmatico
del purgatorio e della preghiera per i morti, duramente messo sotto accusa dai protestanti.
Sullo sfondo di complesse composizioni dinamiche, tipiche della sua maniera, Tintoretto
elabora costruzioni figurative intenzionalmente semplificate, che sembrano portatrici di un
ii
significato particolare. La Madonna con il Bambino adorata dai ss. Marco e Luca costituisce un
buon esempio di tale estrema semplificazione formale: la Madonna appare sotto forma di visione
celeste, priva della dimensione terrestre. Il paragone con le immagini medievali della Madonna
dell’Umiltà che, in seguito al nuovo culto, erano state riproposte nel Cinquecento non più in
versione “terrena” bensì elevate verso il cielo, fa della Madonna di Tintoretto una nuova icona
mimetica pos
- Id prodotto:
-
90637
- Handle IRIS:
-
11562/935559
- ultima modifica:
-
4 novembre 2022
- Citazione bibliografica:
-
Consulta la scheda completa presente nel
repository istituzionale della Ricerca di Ateneo